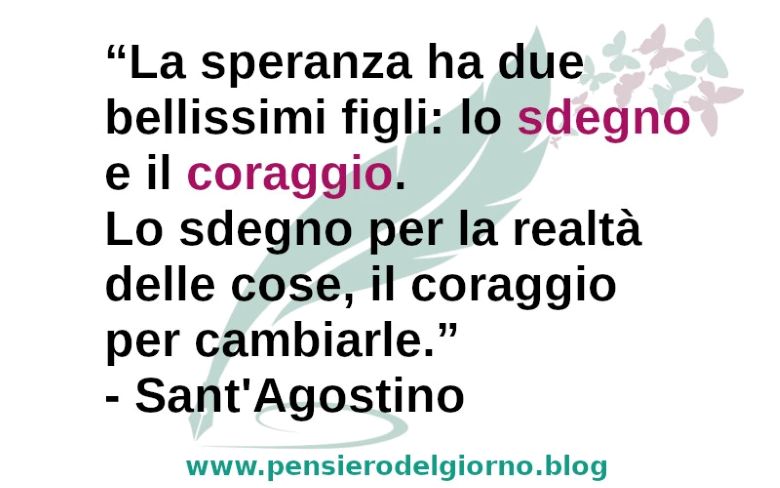Viviamo in un tempo di disorientamento profondo. Un tempo in cui l’uomo ha perso il senso del proprio essere, in cui la società, pur tra mille parole e infinite connessioni, è attraversata da un vuoto incolmabile: il vuoto del significato. Questa è, in un certo senso, l’ironia e la tragedia che ci troviamo ad affrontare. Perché ciò che manca davvero oggi non è solo una leadership o un progetto politico coerente, ma una visione dell’uomo e del suo destino.
La modernità, che prometteva emancipazione e progresso, ha finito per smarrire la direzione. L’ideale di libertà si è trasformato in solitudine, l’eguaglianza in uniformità, la fraternità in slogan privo di carne. La civiltà occidentale, una volta fondata su un’identità condivisa, su un patrimonio di fede, cultura e valori, oggi si frammenta sotto il peso di narrazioni contrapposte, di un relativismo che divora ogni certezza e di un individualismo che isola e divide.
In questo scenario, la speranza appare come il grande assente. Eppure è proprio essa il cuore pulsante di ogni rinascita. Senza speranza, l’agire politico si riduce a mera gestione dell’esistente, l’educazione diventa addomesticamento, la cultura semplice intrattenimento. Ma la speranza — ed è qui il nodo cruciale - non può essere indotta per decreto né ridotta a strategia comunicativa: essa nasce, o non è.
Molti degli eccessi ideologici del nostro tempo non sono che tentativi maldestri di ricreare surrogati di speranza, costruiti a misura di desideri impazienti, incapaci però di durare. Ne sentiamo la mancanza, anche se spesso in modo confuso, subliminale, quasi vergognandoci di ammetterlo. Ma è proprio da qui che può partire una ricostruzione autentica: dal riconoscimento del bisogno. Dal coraggio di dire che qualcosa ci manca.
Ed è qui che entra in gioco una responsabilità particolare per i cristiani. Non perché siano migliori, non perché abbiano una ricetta pronta, ma perché sono sostenuti — o dovrebbero esserlo — da una visione altra, da un orizzonte che non si esaurisce nella cronaca né si rifugia nell’eschaton, ma opera già ora, nel tempo, come promessa che si incarna e trasforma.
Per secoli, la missione civilizzatrice della Chiesa ha trovato espressione non nei proclami, ma nei gesti quotidiani: nella carità silenziosa, nella bellezza delle arti sacre, nel rigore del pensiero teologico e filosofico, nella costruzione di un ordine che, pur tra le contraddizioni, cercava di riflettere la verità del Vangelo. E soprattutto, nella custodia del linguaggio, nel preservare e riformulare parole fondamentali — giustizia, misericordia, dignità, vocazione, comunione — salvandole dalla deriva ideologica o dall’oscuramento semantico.
Oggi quel compito è più urgente che mai. Le controversie attorno a temi come identità, educazione, differenza sessuale, diritti e libertà, rivelano una società che ha smarrito la capacità di dire “noi”, che ha perso di vista lo scopo comune, la meta condivisa. Il tessuto della convivenza si sta sfilacciando da tutte le direzioni contemporaneamente; intere matasse di senso vengono strappate, e con esse vengono meno anche i criteri con cui orientarsi nella vita.
Non vediamo più modelli di nobiltà, né bellezza visibile. L’arte è diventata provocazione sterile, la politica calcolo, la religione spesso un rituale vuoto o una questione privata. È in questo mondo crepuscolare che l’eredità di San Benedetto acquista una nuova luce. Benedetto non scelse la fuga, ma la fondazione. Non maledisse il tempo, ma cominciò a edificare. Con gesti semplici e profondi, ridiede all’uomo il senso del tempo, dello spazio, del lavoro, della fraternità, del sacro. Risvegliò l’aurora, per dirla con il salmo, quando tutto sembrava già notte.
La sua opera fu capace di generare una cultura nuova - lenta, nascosta, ma duratura. E la chiave di tutto fu un’esperienza condivisa, un’unità profonda, che i monaci chiamavano unanimitas: un’unione delle anime, una comunione d’intenti, che rendeva leggere anche le fatiche più pesanti. È questa la qualità che manca oggi, e che occorre urgentemente riscoprire.
Perché ciò di cui abbiamo bisogno non è un programma politico ritoccato, né un ritorno nostalgico a forme passate, ma una rinascita dell’umano. Una riscoperta dell’uomo come essere relazionale, aperto all’altro, capace di trascendenza. Un uomo non ridotto ai suoi istinti, ai suoi consumi o ai suoi algoritmi. Ma un uomo che sa ancora chiedersi perché, che sa ancora inginocchiarsi, amare, contemplare, servire.
Serve una nuova polis, non semplicemente come struttura amministrativa, ma come spazio di comunione viva, come corpo fatto di volti, di storie, di legami. Una polis in cui sia possibile testimoniare insieme, in modo credibile, la verità dell’umano. Non con crociate culturali, ma con la forza mite della vita condivisa, del lavoro ben fatto, della parola limpida, del perdono vissuto, della liturgia che trasfigura.
Ecco allora la sfida: essere comunità che canta l’aurora mentre tutto intorno si prepara alla notte. Non aspettare che la speranza venga da fuori, ma generarla nel cuore della storia, là dove sembra più assente. Come? Iniziando dalle relazioni, dalla famiglia, dall’educazione, dai luoghi di prossimità e di cura. Testimoniando che un altro modo di vivere è possibile.
Carlo Di Stanislao
Fonte foto: https://www.pensierodelgiorno.blog