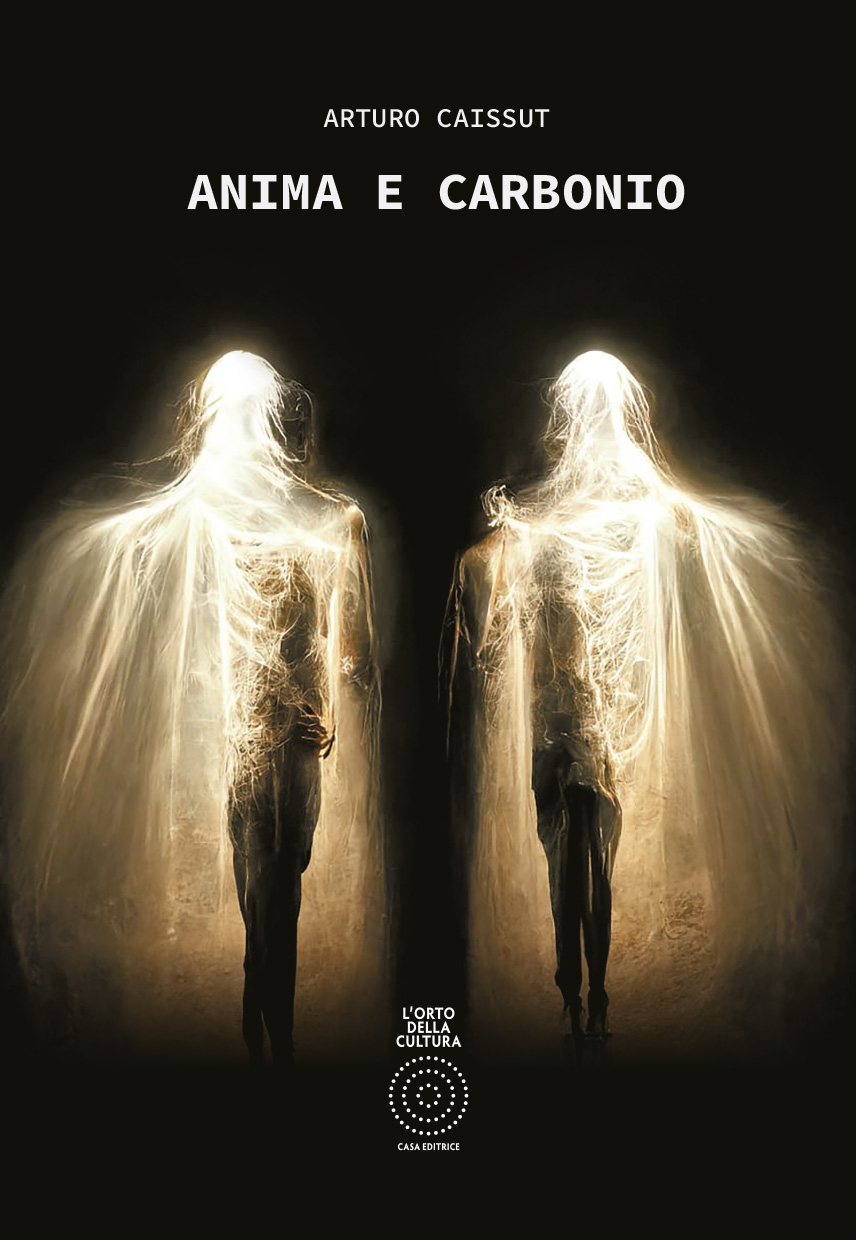di Francesca Ghezzani
Con dieci racconti visionari e sapientemente costruiti,
Arturo Caissut – nella vita Ingegnere Biomedico - ci porta nella dimensione più
affascinante della fantascienza, quella che oltre a ipotizzare il domani offre
l’opportunità della riflessione per l'implicita correlazione con l’oggi.
Anima e carbonio è una raccolta che dal titolo va alla sua sostanza: racconti che trovano sede al confine tra la tecnologia e la coscienza morale e, in ultima analisi, nella materia prima della vita.
Arturo, il protagonista è l’essere umano in epoche disumanizzate. Cosa
si nasconde dietro questo apparente ossimoro?
Credo che tutto parta da una considerazione: siamo una specie
formidabile, il nostro cervello (per quanto ne sappiamo) è l’unica entità
nell’Universo in grado di definire sé stessa. È questa capacità a renderci
umani? Non saprei: di sicuro possediamo un insieme di caratteristiche difficili
da circoscrivere che ci rendono quello che siamo. E penso sia altrettanto
sicuro che in modo figurato o letterale sia possibile perdere alcune di queste
caratteristiche: se smettessimo di provare emozioni ad esempio saremmo ancora
umani? E se costruissimo una macchina tanto avanzata da riuscire a farlo,
avremmo creato un altro essere umano? In quel caso che ne sarebbe di noi? Ho
provato a giocare un po’ con questi e altri interrogativi sul significato della
parola Umanità, spostando il punto focale nel futuro sia per avere più libertà
creativa che per tentare di fare una cosa che è tipica di un certo tipo di
fantascienza: provare timidamente a lanciare dei moniti, indicare alcune strade
possibili e dire “Meglio se cerchiamo di non andare da quella parte, la
destinazione potrebbe non piacerci.”
L’intelligenza artificiale: crisi o opportunità a tuo avviso?
Sono un po’ di parte, avendo lavorato per tanti anni con l’automazione,
l’AI e tematiche affini, però credo che si tratti innanzitutto di una grande
opportunità: sempre più compiti possono essere delegati a surrogati
tecnologici, cosa che implica lasciare più tempo libero a noi per essere
creativi, sognare, inventare. Certo, la paura diffusa di vedersi togliere il
lavoro da una macchina è comprensibile: tutto dipende da quanto saremo bravi e
forse virtuosi a livello sociale e manageriale nell’assicurarci che la
disponibilità di questi strumenti non diventi una leva per indebolire i diritti
dei lavoratori. L’altra paura diffusa relativa all’AI, quella che esploro
anch’io in alcuni punti della mia raccolta, ovvero l’idea per cui prima o poi
le macchine debbano farci estinguere, a mio avviso è meno giustificata. Proprio
ieri ho conseguito un master in Filosofia della Scienza con una tesina che
parlava di questo: ho analizzato la percezione di robot e AI da parte del
pubblico attraverso uno studio di opere di cultura popolare (classici della
letteratura, dell’animazione, del cinema). L’idea che mi sono fatto è che
proiettiamo sulle macchine gli istinti più distruttivi della nostra specie: sospettiamo
che una qualche AI sufficientemente avanzata debba per forza volerci sterminare
perché è quello che noi faremmo al suo posto. Fin dal primo uso documentato
della parola “robot” in letteratura l’esito immaginato dall’autore è stato lo
stesso: ribellione delle macchine, guerra, genocidio. Era il 1920, di lì a
breve avremmo dimostrato per l’ennesima volta che non ci servono robot per
ammazzarci a vicenda.
Troviamo annunciate apocalissi. Quale rimane l’interrogativo più grande
dell’uomo?
Senza ombra di cinismo e con grande serenità: l’Apocalisse prima o poi
arriverà, nel senso che un giorno lontano (speriamo molto) la nostra specie
cesserà di esistere. Potremo prolungare la nostra permanenza sulla Terra
preservandone l’equilibrio, potremo prolungarla nell’Universo se riusciremo a
espanderci oltre il nostro sistema solare per tempo, però prima o poi non ci
saremo più. Questo non è un bene né un male, è semplicemente un fatto. Detto
questo, a mio avviso la domanda più importante è questa: cosa possiamo fare per
rendere migliore possibile il tempo che rimane alla nostra specie? Credo che
ognuno debba trovare la propria risposta, non è necessario essere santi o
filantropi: basta pensare ai nostri figli, nipoti o pronipoti, in senso
letterale o figurato, e pensare a come vorremmo essere ricordati da loro. La
vita umana è breve, quella della nostra specie sarà ancora lunga: se mi
dicessero che morirò domani correrei a piantare un albero di ciliegio in
qualche giardino. Io non lo vedrò fiorire ma qualcuno sì, e magari per quel
qualcuno quell’albero sarà importante.
Scienza e arte: dove trovano il punto di incontro secondo la tua esperienza e formazione?
Si intersecano continuamente: per quanto bello sia il mito romantico del
genio ispirato che non ha bisogno di regole, la realtà è che ogni disciplina
artistica di regole ne ha eccome, specie quelle non scritte, ed è lì che di
solito si trova la scienza. La matematica, ad esempio, è alla base della musica
ma è centrale anche nell’arte pittorica o nella scultura. In paesi come il
nostro si tende a creare una contrapposizione un po’ artificiale tra scienza e
arte già sui banchi di scuola e a mio avviso questo è un peccato: chissà quanti
grandi artisti ci stiamo perdendo tra i ragazzi che pensano che studiare materie
tecniche sia l’unica cosa importante da fare, e chissà quanti contributi
scientifici potremmo avere da ragazzi che in questo momento frequentano il liceo
artistico: le contaminazioni tra discipline diverse sono importantissime e
andrebbero incentivate. Io personalmente ho sempre cercato di seguire entrambe
le spinte: ho studiato Ingegneria ma ho sempre coltivato la scrittura, e credo
che le due cose si siano supportate a vicenda.
In chiusura, cosa
dovremmo imparare dal passato per vivere meglio il presente e progettare il
futuro?
Credo che il passato dia sostanzialmente tre tipi di lezioni: “non rifare
questa cosa”, “rifai questa cosa”, “la prossima volta che farai questa cosa
prima fai questo”. È una suddivisione un po’ semplicistica ma penso che ci
siamo capiti: possiamo imparare dai nostri errori o imparare dai nostri
successi, e la stessa cosa la possiamo fare con gli errori e i successi altrui.
È facile limitarsi agli errori e scoraggiarsi: l’Umanità ha fatto tante cose
tremende e tante altre ne farà, ed è necessario averne memoria per non
ricascarci. Allo stesso tempo, e forse con intensità ancora maggiore, non
dobbiamo cessare di lasciarci ispirare dai grandi del passato ma anche dai
piccoli del passato, anche da noi stessi se è il caso. Forse la grande lezione
del passato è questa: ricollegandomi alla prima risposta, siamo una specie
formidabile, abbiamo la possibilità di fare molto di buono e molto di cattivo.
Sta a noi tenerlo sempre presente.