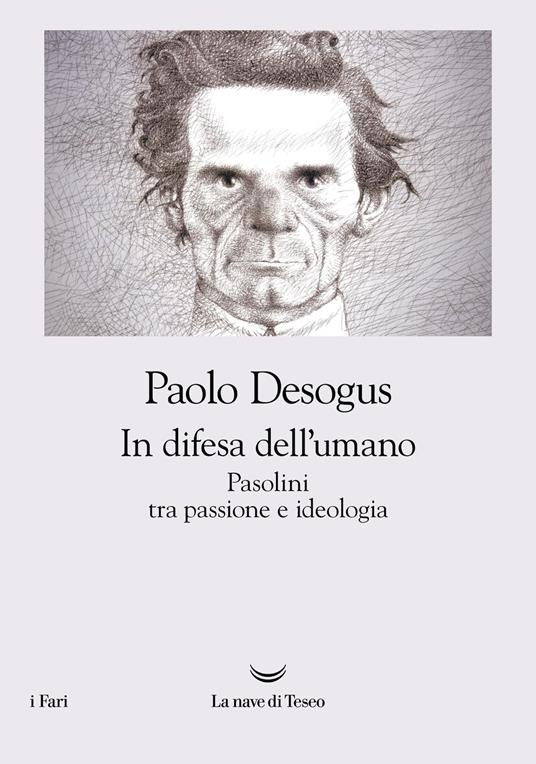A cinquant’anni dalla sua morte, Pier Paolo Pasolini continua a essere una figura centrale nel panorama culturale italiano e mondiale, ma troppo spesso la sua immagine è stata semplificata in un mito comodamente “buono per tutti”. Un mito che ha finito per essere adottato e reinterpretato da schieramenti opposti, da postfascisti a liberali, perdendo così di vista la complessità e la radicalità del suo pensiero politico e artistico. In questo senso, il recente saggio di Paolo Desogus, professore alla Sorbona, rappresenta una tappa fondamentale per una rinnovata lettura critica della figura di Pasolini, restituendogli la profondità e la contraddizione che lo hanno attraversato.
La distorsione del mito e la perdita della dimensione politica
Con il tempo, e soprattutto a partire dagli anni ’70, Pasolini è stato spesso ridotto a voce isolata di denuncia contro un potere anonimo e senza connotati, un potere che viene affrontato quasi esclusivamente sul piano estetico. Tale riduzione ha portato a una destorificazione della sua figura, dimenticando il suo percorso intellettuale fatto di profonde riflessioni marxiste ed esistenzialiste, di un dialogo serrato con il marxismo e con il Partito Comunista Italiano (PCI), da cui non si allontanò mai del tutto, sebbene critico e indipendente.
Desogus ricostruisce questo percorso complesso e tortuoso, mettendo in luce come Pasolini abbia attraversato una profonda trasformazione culturale e politica, partendo da un marxismo di matrice classica fino ad arrivare, negli anni ’60, alla consapevolezza amara che «la rivoluzione non è più che un sentimento» di fronte alla vittoria del neocapitalismo, che egli identificava come la forza corruttrice capace di distruggere l’umano.
Il valore della contraddizione: dialettica e antidialettica
Uno degli aspetti più interessanti del pensiero pasoliniano, e che Desogus mette in rilievo, è il ruolo centrale della contraddizione come elemento costitutivo della sua filosofia e del suo modo di vivere l’arte e la politica. Pasolini stesso ha definito il suo pensiero come «a volte dialettico e a volte antidialettico», un dualismo che attraversa la sua riflessione sulla realtà storica e sulla condizione esistenziale, tra ragione e irrazionalità, storia e mito.
Questa tensione interna è il filo rosso che collega le sue opere letterarie, cinematografiche e giornalistiche, facendo emergere un autore che non si piega a facili classificazioni, ma che costruisce una visione del mondo complessa, stratificata, in cui la contraddizione è non solo una realtà sociale, ma anche un elemento esistenziale.
Pasolini filosofo e intellettuale poliedrico
Contro la leggenda che vuole Pasolini un autore senza teoria né letteraria né filosofica né politica, Desogus dimostra come egli abbia coltivato un’intensa formazione filosofica, iscrivendosi a Filosofia dopo la prima laurea e chiedendo la tesi a Felice Battaglia. Pasolini si è nutrito sin dagli inizi di una ricca gamma di letture psicoanalitiche, antropologiche e linguistiche, confrontandosi con autori come Marx, Freud, Gramsci, De Martino, Benjamin, Fortini, e con le teorie della Scuola di Francoforte.
Questa pluralità di influenze si riflette nella sua opera, che intreccia elementi di marxismo e psicoanalisi per smascherare le ideologie correnti, per denunciare la distruzione del soggetto umano sotto la spinta neocapitalista e per difendere la dimensione umana, religiosa, mitica ed erotica contro la mercificazione crescente della società.
Un artista della realtà subalterna
Pasolini, intellettuale di origine borghese, ha saputo rivolgere la sua attenzione ai subalterni, a quei mondi marginali e spesso ignorati come le borgate romane o i contadini friulani. La sua arte ha sempre cercato di dare voce ai modi, ai linguaggi e ai sentimenti di queste realtà, opponendosi all’astrazione universale che tende a cancellare le differenze e le contraddizioni sociali.
Nel solco della lezione di Gramsci, Pasolini incarna la tensione tra chi comprende e chi sente, tra l’intellettuale e il popolo, in una continua ricerca di un contatto dialettico che non si riduca a un mero tentativo di rappresentazione, ma che si trasformi in un atto politico e culturale di resistenza.
Conclusione: Pasolini come eredità viva e contraddittoria
L’opera di Paolo Desogus ci offre dunque una chiave preziosa per riscoprire Pasolini nella sua interezza, al di là delle semplificazioni mitiche e degli usi strumentali che ne sono stati fatti. Pasolini emerge come un pensatore critico e originale, capace di dialogare con la modernità senza rinunciare alla sua radicalità e alla sua passione civile.
In un’epoca in cui le contraddizioni sociali e culturali sembrano più vive che mai, rileggere Pasolini significa anche riaffermare il valore della cultura come campo di battaglia e della critica come strumento indispensabile per difendere l’umano dall’avanzata delle forze distruttrici del neocapitalismo.
Come scriveva Goffredo Fofi senza contraddizioni e contradditorio non può esservi Cultura
Carlo Di Stanislao